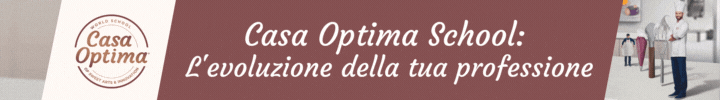La risposta è sì, periodicamente e all’interno di obiettivi e perimetri ben tracciati. Il fenomeno delle aggregazioni o associazioni negli ultimi decenni è stato analizzato da molti studiosi, ma solo ultimamente si avverte in modo evidente l’esigenza di verificarne il ruolo e l’efficacia in virtù delle evidenti trasformazioni che connotano le dinamiche della competizione nazionale e internazionale. Grazie all’intensificarsi della concorrenza, frutto anche della globalizzazione, oggi alle imprese viene chiesto un maggiore sforzo sia in termini di risorse e competenze, sia di visione. Questo vale, a maggior ragione, per i mercati emergenti, per lo sviluppo verso i quali quelle stesse imprese devono adottare strategie commerciali maggiormente articolate e devono confrontarsi con le difficoltà legate alla più grande distanza geografica, culturale e normativa che li caratterizza. Fattori che si rivelano critici soprattutto per le imprese minori, ovvero quelle che hanno più difficoltà nel disporre di risorse (finanziarie, di competenze, organizzative) utili al presidio di mercati per i quali strategie di ingresso si rivelano sempre meno adeguate. Pertanto, la funzione delle reti di relazioni, per le potenzialità che esse possono esprimere, tende ad acquisire un ruolo centrale: se in passato le aggregazioni fra imprese per lo sviluppo di se stesse potevano rappresentare un’opportunità per rafforzare il vantaggio competitivo, oggi diventano una necessità, rispetto alla quale cambia anche il grado di motivazione delle medesime imprese. Essere soli, in poche parole, ad affrontare il mercato, oggi non è più una strategia vincente. E allora? Come muoversi adeguatamente e in gruppo, mantenendo fede alla propria identità, storia, filosofia…? Come trovare il giusto compromesso tra quello che è il mio spazio d’azione e il tuo spazio d’azione? Come tracciare i giusti perimetri tra le diverse organizzazioni che popolano lo stesso ambiente economico, senza che queste si pestino i piedi, ma, anzi, proprio grazie alle loro expertise siano generatrici di valore aggiunto? Immaginatevi una piazza. Fino a qualche tempo fa popolata da un solo un bar, un solo ristorante e due negozi di abbigliamento. Bene, nonostante la sua superficie e l’offerta, questa rimaneva poco frequentata, se non da avventori abitudinari. Immaginatevi, poi, a distanza di pochissimi metri, un’altra piazza dalle stesse dimensioni, ma con due gelaterie, tre bar, due ristoranti, una trattoria, una pasticceria, e quattro negozi di abbigliamento. Tutti in concorrenza tra loro. Secondo voi, la gente, i consumatori, in quale piazza andranno? Il flusso di persone dove si concentrerà maggiormente? La risposta non può che essere una: nella piazza in cui i commercianti hanno saputo aggregarsi, vincendo il timore della sovrapposizione e dell’ormai superato ideale monopolistico, sempre meno apprezzato dal consumatore, tra l’altro, che sceglie invece, di vivere ancor prima dei prodotti, una esperienza, ma non solo.
Questo contributo si pone l’obiettivo di stimolare l’attenzione dei professionisti del settore, dei produttori di semilavorati e di macchinari, dei distributori specializzati, dei media, delle Associazioni di Settore e delle Fiere specializzate, in una parola, della filiera del gelato artigianale tutta, verso una diversa forma di collaborazione tra le parti. Una forma di cooperazione che oggi necessita, a mio avviso, di essere fortemente incentivata a modificarsi, non tanto per la numerica di attori esistenti sul territorio nazionale, ma per l’inabilità che questi ultimi esprimono nell’interagire tra loro e muoversi verso obiettivi comuni. Se fino a qualche anno fa si assisteva a una moria di organizzazioni territoriali, oggi la tendenza, che voglio leggere positivamente, sta nel constatare la nascita di una quantità enorme di gruppi di cooperazione, ciascuno dei quali con qualità e potenzialità gigantesche, ma che se non fatte convogliare in progetti comuni, rischiano di disperdersi nel mare magnum, a discapito, ancora una volta, del prodotto e dell’artigianalità. Ma perché le aggregazioni funzionino e possano generare effetti positivi, vi è bisogno di complementarità e integrazione tra i vari protagonisti, in virtù del loro elevato grado di varietà in termini di obiettivi, prodotti, risorse, culture organizzative e capitali umani. Osservando il funzionamento e i risultati raggiunti da svariate sistemi di collaborazione, si è rilevato che una delle condizioni essenziali che contribuiscono al loro successo è la presenza di una coesa “comunità morale”. In definitiva, la presenza di un profondo coinvolgimento da parte dei sistemi aderenti contribuisce ad aumentare le probabilità di successo dell’iniziativa di carattere aggregativo. Ciò a significare che, ancora una volta, se si prescindono valori, passioni, motivazioni, sogni e aspirazioni: numeri abbinati a stratosferici organigrammi di gestione non basteranno mai. C’è bisogno di ritrovare obiettivi comuni da condividere, grazie ai quali tracciare precise strategie che vedano gli attori della filiera motivati!
C’è bisogno di ritrovare lo spazio e il tempo in cui vedersi, confrontarsi, senza che questo venga inteso come una mera perdita di tempo. Sarà solo così facendo, ovvero dando il giusto valore a progetti comuni, che si potranno evitare figure barbine come quella che ci ha visti ridicolizzati all’interno di una trasmissione tv, andata in onda fortunatamente la mattina di un sabato su una rete nazionale di qualche settimana fa: una preziosa occasione in cui avremmo potuto rivolgerci al consumatore finale, rappresentando lui, il gelato e l’intera filiera, andata sprecata perchè inghiottiti dall’incedere di un evidente strumentalizzazione del tema a discapito del settore artigianale tutto. A testimoniare che per fare bene e sul lungo periodo, non bastano singole azioni o singole persone (potenzialmente o poco rappresentative o iper-responsabilizzate o, nella peggiore delle ipotesi, eccessivamente focalizzate sul proprio ego), ma servono azioni corali e condivise ex ante. E allora, non posso non pensare al ruolo fortemente proattivo che potrebbero avere talune fiere di settore, quali driver e importanti connettori di reti di relazioni, ma non solo, tra gli attori della filiera! Quali centri di ritrovo in cui muovere cultura, simposi verticalizzati su temi di volta in volta diversi, e quindi progettualità condivisa con obiettivi e sfide comuni: co-attori, unitamente a tutti i protagonisti della Filiera, di appuntamenti ad hoc, da temporizzare annualmente, che si prefiggono finalità da raggiungere; coordinatori in cui far confluire bisogni e domande, producendo precise risposte e conseguenti soluzioni. Pensiamo ad esempio alla fatica che ognuno di noi fa nel reperire dati, numeri, indicazioni, ma più in generale, studi di settore dedicati, fondamentali per le organizzazioni tutte nella strutturazione delle di ciascune progettualità. Pensiamo anche alla polverizzazione, senza senso, di tante informazioni che potremmo dare, coordinatamente, alla stampa destinata ai consumatori finali, che invece, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, è costretta a rivolgersi più o meno casualmente ai diversi attori della filiera, senza che vi sia unitarietà di comunicazioni, o peggio ancora, senso comune.
E allora come interpretare le fiere del domani? Quali straordinari iniziatori di cambiamento culturale e nuove forme di aggregazioni finalizzate alla costruzione e alla tenuta di quella stessa comunità morale di cui si scriveva sopra. Una comunità di cui andare ancora molto fieri, ma che a mio parere necessita di essere velocemente attenzionata prima che perda di qualità e scopi, inghiottita dall’incedere di un’economia sempre più spersonalizzata e anonima.
Abbiamo di fronte una grande sfida, supportata da un altrettanto enorme opportunità: a noi saperla cogliere e portarla a fioritura.
di Aurora Minetti